Nonostante i dati rilevati in Italia e nel mondo mostrino un trend crescente di adozione dello smartworking, si nota quanto sia in realtà un fenomeno che fatica ancora a farsi spazio tra le paure ed i pregiudizi indotti dal cambiamento di mentalità che lo smartworking richiede.
Si perché sia in territorio italiano che internazionale non è raro leggere o sentire commenti diffidenti su questa modalità di lavoro della serie: “lavori da remoto o remotamente lavori?”
A creare ancora più confusione ci sono i vari termini smartworking, lavoro agile, telelavoro che spesso vengono mescolati tra loro mentre sono di fatto stadi evoluti di un concetto di modernizzazione del lavoro che si sono purtroppo susseguiti velocemente, “senza passare dal via” come si direbbe nel gioco dell’oca, ovvero senza che siano effettivamente stati ben compresi, accettati ed adottati dalla società.
A completare il quadro di questa rarefatta padronanza c’è poi il web, che alla parola smartworking, mostra immagini alternate tra persone ai caraibi a mamme/papà che lavorano da casa in preda ai capricci dei propri bambini, dando quindi una idea completamente forviata del modello e che portano quindi a concludere che lo smartworking non è adatto proprio a tutti, aziende e lavoratori compresi.
In prima istanza si sarebbe portati ad affermare che l’aspetto che più interferisce con la reale applicazione di questo modello è quello culturale.
Le ragioni non solo però da ricercare solo all’interno delle abitudini e schemi mentali delle persone, ma affonda le sue radici ancora più in profondità in un contesto più ampio, internazionale e storico, da collocarsi nel periodo della prima rivoluzione industriale, ovvero intorno al 1870.
Il processo di modernizzazione che ha portato il sistema agricolo/artigianale ad evolversi in un sistema industriale ha avuto come grande effetto l’accentramento del sistema produttivo. Il luogo di lavoro quindi originariamente collocato nei pressi (se non all’interno) delle abituazioni dei lavoratori, si è spostato all’interno di fabbriche e poi, in fase successiva, negli uffici. Assistiamo quindi ad un allontanarsi della sede lavorativa da quella abitativa, dando luogo di fatto al fenomeno del pendolarismo.
Quello che prima il telelavoro e adesso lo smartworking stanno “chiedendo” è quindi una importante inversione di marcia nella quale il lavoratore, sfruttando l’ulteriore e rapida evoluzione tecnologica degli anni 2000, può ritornare ad erogare le sue prestazioni in un luogo che permetta maggiormente di soddisfare l’esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e quella personale; sia esso la propria abitazione o qualunque altro luogo consono al lavoro.
Una forte richiesta di cambiamento dunque che genera una naturale paura e diffidenza, il timore cioè di uscire dalla propria confort-zone, di non riuscire a governarne il processo.
Per riuscire quindi ad applicare realmente lo smartworking è necessario rispondere alla paura del cambiamento con un naturale adattamento, tipico della specie umana, che permetta di far emergere nelle figure professionali di dirigenti e dipendenti nuove capacità ed abilità svincolate dal concetto spazio/tempo ed orientate al raggiungimento degli obiettivi comuni, colmando lo spazio che c’è tra i due mondi con nuove idee e modelli legati alla coordinazione, la responsabilizzazione e la comunicazione continua.
Questi aspetti, uniti ad un uso più consapevole delle tecnologie abilitanti, possono concretamente permettere di portare avanti con successo un progetto orientato alla flessibilità.
Lo smart-working richiede quindi smart-workers che si sviluppino in modo assolutamente congiunto tra dipendente e dirigente, che sono di fatto la faccia della stessa “smart-medaglia”.
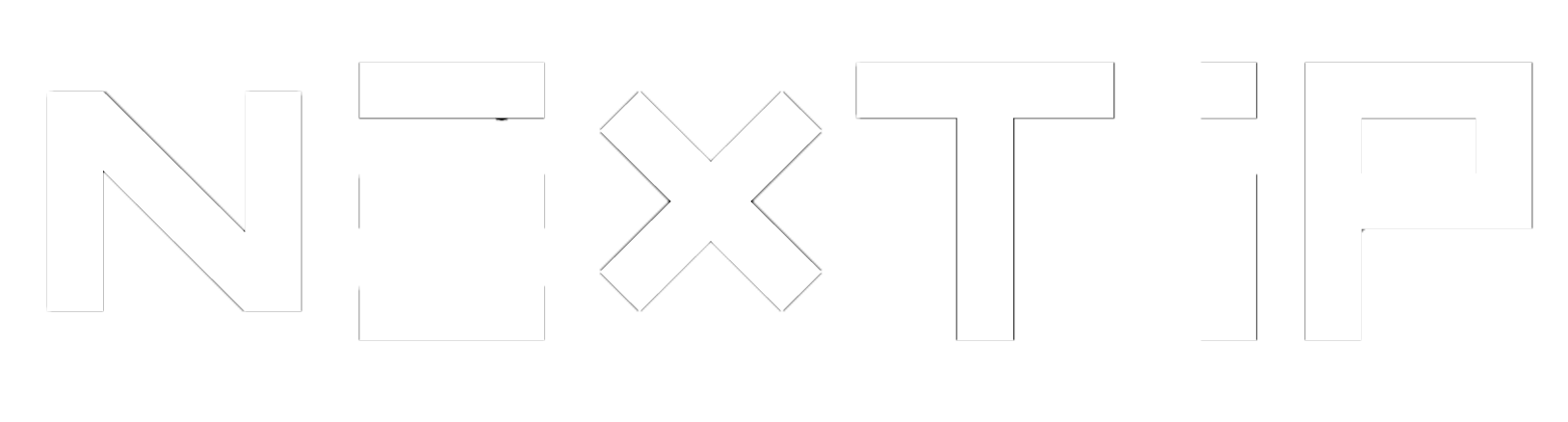


 November 16, 2017
November 16, 2017